
Teoria e pratica della disruption
Sin da Joseph Schumpeter, l'economista austriaco eterodosso che agli albori del novecento con due pubblicazioni straordinarie aprì gli occhi al mondo sull'importanza della crescita e dei cicli economici, la letteratura conosceva solo due tipi di innovazione: quella radicale e quella incrementale. C'erano la macchina a vapore, le ferrovie, la prima automobile. Innovazioni che avevano cambiato il mondo, per parafrasare un libro famoso di MIT: appunto "radicali" perché proponevano una nuova idea di prodotto attraverso una nuova tecnologia. Ma il successo dipendeva anche dalla capacità di imitare, di differenziarsi dai concorrenti, dal sapere servire meglio un mercato, senza mutare il concept di prodotto e la tecnologia, ovvero la capacità di fare innovazioni "incrementali", che cioè innovano in misura evolutiva. Ad esempio, quando sagacemente Alfred Sloan a capo della General Motors ebbe l'idea di vendere automobili "for every purse and every purpose" scalzò la quota di mercato dominante della Ford che credeva che il prezzo aggressivo e la funzionalità del suo Modello T monocolore fossero sufficienti a dominare il mercato.
Ma poi, nel 1997, venne Clayton Chrinstensen. La pubblicazione della sua tesi di dottorato sull'industria informatica dei disk drive, che sfociò nel libro Innovator's dilemma. When new technologies cause great firms to fail, bestseller di New York Times e Financial Times, ci introdusse al termine "disruption", una terza categoria di innovazione. Essendo Clayton anche molto religioso ed essendo stato nel tempo mitizzato a "guru" da molti manager, a leggere la sua biografia oggi sembrava fosse un predestinato. Laurea per motivi religiosi nella mormona Brigham Young University con major in economia, MPhil ad Oxford, MBA ad Harvard e poi una carriera molto promettente da consulente in multinazionali come BCG, con la decisione inusuale in età piuttosto avanzata di intraprendere presso la stessa Harvard un PhD, che conseguì oramai quarantenne. L'allora assistant professor di strategia e tecnologia di Boston osservò che in alcuni mercati l'innovazione è ben più subdola di quanto ci si era resi conto fino ad allora. Il classico caso delle mini-fotocopiatrici aiuta a capire meglio cosa si intende per "disruptive innovation".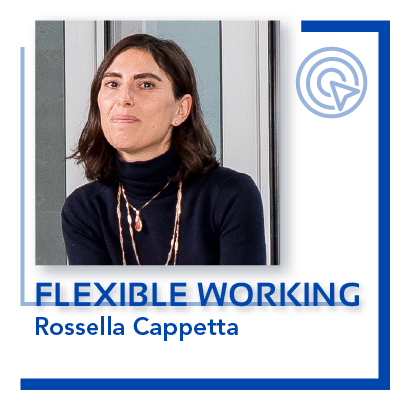



La mini-fotocopiatrice da tavolo è equiparabile a una stampante e in quanto tale non può certo definirsi una innovazione tecnologica radicale rispetto alla xerografia. Definirla incrementale è altresì limitante in quanto per idearla e svilupparla è necessario snaturare l'architettura del prodotto dotandola di componenti tecnologi non solo più piccoli ma anche caratterizzati da una interdipendenza ingegneristica in spazi più limitati che impone nuovi elementi e ne esclude altri. Il suo lancio cambiò per sempre il mercato. Nonostante infatti il prodotto fosse stato concepito per piccoli uffici e per privati che non si potevano permettere le grandi e performanti fotocopiatrici Xerox, e in quanto tale presentava prezzo e performance più contenute, la determinazione di Canon di lavorare sulla qualità tecnologica nel tempo e mantenere un prezzo relativamente inferiore ha permesso negli anni di cambiare i gusti dell'intero mercato e di renderlo il concept più desiderato.
Disk drive e mini-fotocopiatrici a parte, il merito di Christensen, come evidenzia anche il sottotitolo del suo libro, non è tanto legato a identificare una terza categoria di innovazione a metà tra incrementale e radicale, ma nell'illustrare le conseguenze che essa ha sulle grandi multinazionali –motivo dell'enorme successo del suo modello. Nella casistica analizzata infatti le grandi aziende hanno spesso in pancia le innovazioni disruptive. E sarebbe strano che non le avessero visto che spendono budget di Ricerca e Sviluppo che da settore a settore variano dal 3% al 25% del fatturato. Il problema è che però anche quando le brevettano non hanno poi la forza di lanciarle sul mercato perché ascoltano troppo i loro clienti serviti e non hanno il coraggio di cannibalizzare la quota di mercato dei loro stessi prodotti. Ecco quindi che qualche concorrente proveniente da altri settori o in forma di startup in assenza di queste inerzie cognitive ed economiche la lancia e nel tempo diventa un vero e proprio "disruptor" costringendo l'azienda leader improvvisamente a seguire anziché a guidare il mercato. Queste innovazioni disruptive tra l'altro entrano nelle fasce di mercato più basse e si posizionano progressivamente su quelle più alte perché rendono il nuovo concept quello alla lunga dominante nel mercato. Celebre in proposito il caso di Sony, che aveva il brevetto dell'MP3 ma che non volle sfidare Napster nel mondo digitale della distribuzione di contenuti nel 1999, salvo poi rendersi conto che con l'introduzione dell'iPod da parte di Apple nel 2001 il mondo avrebbe voluto non più CD ma MP3.




Il successo della teoria è legato anche al momento della sua uscita, quando ovvero il mondo stava diventando più digitale e guidato dalle logiche di internet e dei social. Molti servizi e prodotti emersi nel mondo digitale richiamano le logiche appena evidenziate e sono stati associati alla disruption. La piattaforma Airbnb è in proposito un esempio calzante: non può certo definirsi una innovazione radicale (non ha creato un nuovo servizio di hotellerie) né incrementale (non ha segmentato verso l'alto o il basso l'hotellerie). Nata come soluzione economicamente efficiente e con qualità di servizio variabile (i clienti degli appartamenti, come noto, non sono professionisti, bensì sono normali proprietari che decidono di rendere disponibile la propria abitazione) per risolvere il problema delle prenotazioni in destinazioni "fully booked" e ignorata dai grandi del settore quali Marriott e Sheraton, la piattaforma ha pian piano dal "basso" del mercato ridefinito il concept di servizio nel settore turistico, diventando leader di mercato e portando negli anni gli stessi leader del settore a seguirne il comportamento.
La teoria della disruption è stata validata da tanti casi studio e da diverse analisi settoriali portate avanti da Christensen e da colleghi attraverso replication studies. Ma è stata anche falsificata in vari spunti offerti dal modello originale e anche pesantemente criticata per l'eccessiva banalizzazione e divulgazione che ha prodotto. Celebri le stroncature della storica di Harvard Jill Lepore sul New Yorker, o il più sofisticato articolo del collega Andy King di Boston University su Sloan Management Review. Addirittura in un celebre special issue su Disruptive Innovation di una rivista specialistica molto seguita negli studi di innovazione, Journal of Product Innovation Management, l'editoriale accusava la teoria di rischiare di essere pericolosa in quanto fosse stato costituito un fondo sulle disruptive innovation che avrebbe dovuto chiudersi alcuni anni dopo la sua apertura per incapacità di identificarle correttamente.
Christensen è mancato prematuramente due anni orsono. Oggi se googliamo "disruption" otteniamo 160 milioni di risultati. Con l'espressione "disruptive innovation" si dimezzano, ma rimangono 71,5 milioni. Clayton Christensen ne ha "solo" 10,5 milioni. A dimostrazione che la parola disruption nel gergo manageriale e pubblico ha perduto il significato tecnico per abbracciare invece un'espressione cara ai manager in questa epoca digitale. Come dire... la disruption ha creato una disruption nel mondo scientifico e manageriale.
Nella sua forma più sobria e originale è tuttavia ancora oggi insegnata nei corsi di gestione tecnologica e inclusa nei principali manuali di technology management. A dimostrazione della solidità dell'idea e dell'importanza delle implicazioni che da essa scaturiscono. Più in generale, per chi fa ricerca il modello della disruption ci ricorda l'importanza della costante tensione tra solidità e impatto: il rigore deve essere messo in primo piano, ma è importante che sia indirizzato a temi che aiutino le nostre audience a migliorare la loro consapevolezza e conoscenza dei temi che gestiscono.