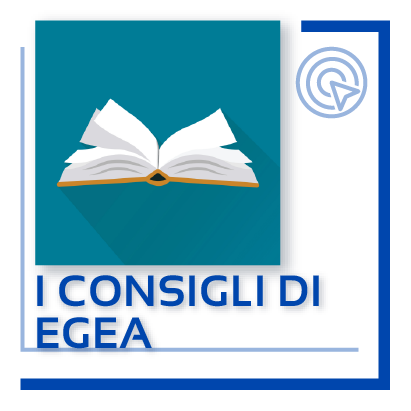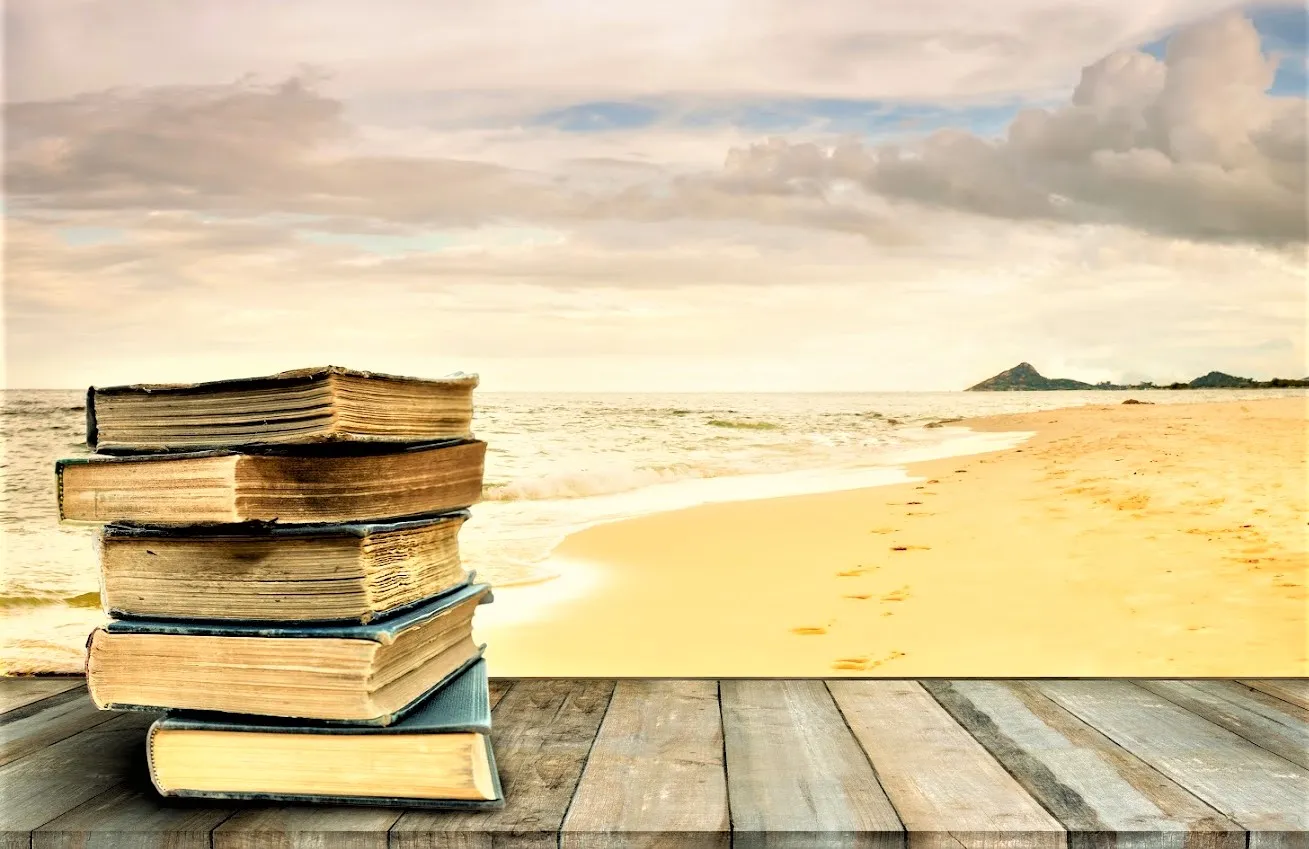
Letture estive, i consigli dei prof…
Una lettura estiva non dev'essere per forza una lettura disimpegnata. Può essere divertente, appassionante, coinvolgente. Può farci conoscere cose nuove o mostrarci cose che già conoscevamo sotto una prospettiva diversa. Che sia un romanzo, un saggio o un testo più specialistico, una buona lettura ci lascia sempre qualcosa, arricchisce la mente e lo spirito. E così, sia che ci accingiamo a trascorrere le imminenti vacanze estive su una spiaggia assolata, al fresco della montagna o in una città d'arte, in Italia o all'estero, portare con noi qualcosa da leggere è sempre una buona idea. Ma cosa mettere in valigia o nello zaino? Lo abbiamo chiesto ai direttori dei dipartimenti dell'Università (Tito Boeri, Emanuele Borgonovo, Cesare Cavallini, Vincenzo Galasso, Miles Gietzmann, Stefano Rossi, Gaia Rubera, Marco Tortoriello e Riccardo Zecchina) che insieme hanno così composto una piccola biblioteca che mescola le passioni di ciascuno con i temi di ricerca che caratterizzano il loro dipartimento. Ecco i loro consigli.
Tito Boeri: intelligenza artificiale, guerra e politica fiscale, tre temi di drammatica attualità
"E' come un fiume, possiamo cambiarne un po' l'orientamento, ma non possiamo fermarlo", spiega Tito Boeri, direttore del Dipartimento di economia, introducendo il suo primo consiglio di lettura, Power and Progress, di Daron Acemoglu e Simon Johnson. "Questa è la tesi sostenuta dagli autori a proposito dell'intelligenza artificiale e dei suoi continui progressi. Un libro che indaga il nostro rapporto con l'innovazione e il progresso tecnologico e lo fa con sguardo piuttosto pessimista". Un libro sull'economia, anzi sugli economisti, è invece How economics can save the world, di Erik Angner: "L'autore spiega come lavorano gli economisti e come l'economia, in modo non presuntuoso, ci possa fornire gli strumenti necessari per risolvere i principali problemi di oggi". Why we fight: the roots of war and the paths to peace, di Christopher Blattman, è invece un libro drammaticamente attuale: "Perché combattiamo, quali sono le ragioni della guerra, un libro a metà tra economia e politologia che ci dimostra", spiega Boeri, "come i motivi che spingono i popoli a combattersi non sono quasi mai strettamente economici, ma legati alle qualità delle istituzioni e alla mancanza soprattutto di contrappesi, di sistemi di checks and balances". Il quarto libro, The voltage effect: how to make good ideas great and great ideas scale, di John A. List, affronta un tema molto importante nella valutazione delle politiche economiche: "The Voltage effect spiega come le idee alla base delle politiche siano in genere pensate su piccola scala e la domanda che bisogna sempre porsi quando le si valuta dovrebbe essere: supponendo che le politiche riescano a raggiungere i loro obiettivi, è possibile replicarle anche su scala maggiore e generalizzarle?". L'ultimo volume consigliato da Boeri è A monetary and fiscal history of the United States, 1961-2021, di Alan Blinder: "Concentrandosi sugli sviluppi più significativi e sui cambiamenti a lungo termine, Blinder ripercorre gli alti e i bassi della politica monetaria e fiscale negli Stati Uniti, che negli ultimi sessant'anni hanno collaborato e si sono scontrate in molte recessioni e in diversi lunghi boom". Un libro pieno di stimoli, a cavallo tra la macroeconomia e la storia economica.
Emanuele Borgonovo: matematica e statistica per comprendere il mondo. In modo divertente
Lo sapete che la matematica è stata decisiva nella battaglia dell'Atlantico? Oppure che, grazie a essa, è stato possibile progettare le ancore? O, ancora, che con la matematica è stato possibile fronteggiare un'epidemia di colera nella Soho vittoriana? "Lo spiega in modo divertente", racconta Emanuele Borgonovo, direttore del Dipartimento di Scienze delle decisioni, "Thomas William Korner nel suo The Pleasures of Counting, un libro di grande successo nel quale è bene evidenziato l'utilizzo della matematica per risolvere problemi pratici di svariate tipologie. Problemi a volte banali, altre di grande importanza nella storia dell'umanità". Un altro libro che Borgonovo consiglia ha per tema la statistica e l'importanza di saper interpretare i dati: "The Art of Statistics, di Sir David Spiegelhalter, descrive in modo piacevole questa importante disciplina e l'autore, prendendo spunto da problemi del mondo reale per introdurre questioni concettuali, ci mostra come la statistica può aiutarci a determinare il passeggero più fortunato del Titanic, se il serial killer Harold Shipman avrebbe potuto essere catturato prima e se lo screening per il cancro alle ovaie è vantaggioso. Illumina il modo in cui possiamo utilizzare la crescente mole di dati per migliorare la nostra comprensione del mondo". Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decision making, di Ralph Keeney, esamina il modo in cui generalmente ci prepariamo a prendere le decisioni. Con un esito sorprendente. "Secondo Ralph Keeney, il modo standard di pensare alle decisioni è al contrario: le persone si concentrano prima sull'identificazione delle alternative piuttosto che sull'articolazione dei valori", dice Borgonovo. "Si presenta un problema e le persone reagiscono, ponendo l'accento su scelte meccaniche e fisse invece che sugli obiettivi che danno significato al processo decisionale. In questo libro, Keeney mostra come il riconoscimento e l'articolazione dei valori fondamentali possano portare all'identificazione delle opportunità decisionali e alla creazione di alternative migliori. L'intento è quello di essere proattivi e di selezionare decisioni più interessanti su cui riflettere prima di tentare qualsiasi soluzione".
Cesare Cavallini: tre romanzi con i giuristi al centro
Tre libri diversi, a cui approcciarsi in modo differente. Ma, tutti, adatti a una lettura estiva, sia che si cerchi la leggerezza sia l'impegno. "Il primo volume che voglio citare", racconta Cesare Cavallini, direttore del Dipartimento di studi giuridici, "è One L, di Scott Turow, un romanzo autobiografico che racconta l'esperienza nel primo anno dello stesso autore nel più antico, grande e stimato centro di formazione giuridica degli Stati Uniti, la Harvard Law School, un susseguirsi di trionfi, di depressioni ed euforie, di lavoro compulsivo, di competizione comune agli studenti di legge di tutto il mondo e quantomai attuale. Una lettura avvincente e in un certo senso leggera". Ben diversa da quella, impegnativa, di Il giorno del giudizio, di Salvatore Satta, una sorta di testamento spirituale ambientato in Sardegna "da parte di colui che è stato", riprende Cavallini, "uno dei più grandi giuristi italiani. Questo libro andrebbe letto non solo per la storia che racconta, ma anche per il linguaggio adoperato, un italiano altissimo, come raramente capita di incontrare". La terza lettura, anche questa un romanzo, è opera di un docente del Dipartimento di studi giuridici, Filippo Annunziata: "Le ragioni per le quali si dovrebbe leggere Obiter dicta, questo il titolo, sono molteplici. La principale, per riscoprire Gino Gorla, uno dei più grandi maestri della comparazione giuridica del '900, come efficacemente scritto da Giuliano della Massara, poi per interrogarsi su alcune questioni fondamentali e irrisolte degli studi storico-comparatistici, in particolare il rapporto tra i grandi sistemi e l'effettivo ruolo della giurisprudenza nell'evoluzione del diritto europeo; infine, ma non meno importante, per riflettere sui percorsi accademici e sulle regole che governano la ricerca giuridica e il percorso dei giovani studiosi, futuri professori". "Anche questo un romanzo che", conclude Cavallini, "per impegno di lettura, costituisce un giusto mezzo tra i due volumi precedenti".
Vincenzo Galasso: il merito è davvero l'unico criterio possibile?
Il criterio del merito, la meritocrazia, ha certamente molti vantaggi per la società, ma ha anche qualche difetto e controindicazione, come spiega nel suo libro, La tirannia del merito, il filosofo Michael Sandel: "Una società meritocratica ha sicuramente due vantaggi", spiega Vincenzo Galasso, direttore del Dipartimento di scienze sociali e politiche, "il primo di efficienza, soprattutto economica, perché alloca le persone migliori nei posti migliori; il secondo, se vogliamo, di giustizia, perché consente di creare una società in cui non prevalgano altri criteri, come per esempio le conoscenze. Tutti quindi possono aspirare a raggiungere i massimi traguardi". Ma non è tutto oro quel che luccica. "Per prima cosa, secondo Sandel, già nascere con determinati talenti è del tutto casuale e non ascrivibile ad alcun merito", dice ancora Galasso, "e quindi il merito è solo una delle componenti. Altre possono essere il periodo e il luogo di nascita, l'essersi trovati nel posto giusto al momento giusto. Prendiamo per esempio un grande calciatore, uno di quelli che guadagnano milioni per la loro abilità con il pallone tra i piedi. Fosse nato in un'epoca in cui il calcio non esisteva questa sua abilità non sarebbe servita a niente". Nel suo libro però Sandel fa anche un passo in più, come racconta ancora Galasso: "Le persone che giungono in vetta non si rendono conto di questa componente di casualità e tendono a essere arroganti e sprezzanti verso chi non raggiunge gli stessi obiettivi. In pratica, secondo questa visione, se una persona non riesce a emergere le responsabilità sono soltanto sue. In America questo è molto vero e ha finito con il creare un mondo polarizzato tra ricchi e poveri". Quindi, in conclusione, la meritocrazia è un buon criterio, in mancanza di migliori, ma alcuni aspetti possono diventare perniciosi e determinare un ambiente troppo competitivo. "La meritocrazia finisce quindi per assumere un valore morale che non ha", conclude Galasso, "e questo è un aspetto molto interessante. Quello però che Sandel non riesce a fare è indicare delle alternative".
Miles Gietzmann: come sarà la blockchain del futuro?
La maggior parte delle persone ha sentito parlare di Blockchain e spesso crede che abbia a che fare con le criptovalute. La Blockchain è in effetti il motore di gestione dei dati che rende possibili criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, ma in realtà può fare molto di più. "La blockchain fa parte della Distributed Ledger Technology (DLT) che può consentire alle aziende di condividere informazioni contemporaneamente con fornitori e clienti o di creare token non fungibili che assicurano la provenienza e la proprietà originale. Queste sono solo due delle molte classi di sistemi Distributed Ledger che alcune aziende stanno esplorando", spiega Miles Gietzmann, direttore del Dipartimento di Accounting della Bocconi. "Nel nostro dipartimento, invece di concentrarci sulle criptovalute ad alto rischio, stiamo per iniziare il quarto anno di un corso (senza criptovalute) di 'Blockchain Design and Use'. Per chiunque operi nel mondo del business oggi è importante prevedere quali potrebbero essere gli effetti dello sviluppo della Blockchain alimentata dal Web3 sui propri modelli di business, che si tratti di assicurazioni, asset custody, vendite o altre attività. Il libro 'The Story of the Blockchain: A Beginner's Guide to the Technology That Nobody Understands' di Omid Malekan è un'introduzione non tecnica a come la tecnologia è stata sviluppata e dà al lettore la possibilità di capire come potrebbe svilupparsi".
Guardando oltre il mondo dell'accounting, Gietzmann suggerisce anche la lettura di 'Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology' di Chris Miller, vincitore del premio Business Book of the Year 2022 del Financial Times. "Dobbiamo avere una visione a lungo termine di dove ci sta portando la tecnologia e questa è un'ottima lettura sulla competizione globale nel settore dei semiconduttori - l'importanza dello sviluppo e della produzione di chip per computer, dominata fino a poco tempo fa dagli Stati Uniti e dai Paesi asiatici (Taiwan in particolare), ma con l'Europa che ora sta cercando di entrare nella mischia, e gli aspetti economici e geopolitici che ci sono dietro".
Stefano Rossi: scienza assicurativa, storia finanziaria e ricerca scientifica, anche umanistica, per riflettere su passato, presente e futuro
"Pensando ad alcune delle materie del dipartimento e alle mie passioni personali", dice Stefano Rossi, direttore del Dipartimento di Finanza, "suggerisco tre categorie di letture. Nella prima, sul tema della ricerca scientifica, The Undoing Project, di Michael Lewis e Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, di Richard Thaler, parlano della nascita della finanza comportamentale, tracciando il percorso dei suoi fondatori Daniel Kahneman, Amos Tverski e lo stesso Thaler, e raccontano il processo della scoperta scientifica in finanza. Il terzo, un romanzo di Dario Ferrari, La ricreazione è finita, racconta la vicenda di un ricercatore in materie umanistiche, e come la ricerca significhi a volte trovare quello che non ci si aspetta." La seconda categoria è sul tema della scienza assicurativa, non più una materia vecchia e polverosa ma una disciplina dinamica in rapida evoluzione: "Suggerisco Risky Business: Why Insurance Markets Fail and What to Do About It, di Liran Einav, Amy Finkelstein e Ray Fisman, e Financial Economics of Insurance, di Ralph S.J. Koijen and Motohiro Yogo. Danno una visione dell'insurance che verrà, vista dalla prospettiva della finanza applicata ai big data. Il primo è molto discorsivo e adatto a tutti; il secondo, invece, più rigoroso, è destinato a studenti universitari". L'ultima categoria è quella della storia finanziaria. American Default: The Untold Story of FDR, the Supreme Court, and the Battle over Gold, di Sebastian Edwards, narra una vicenda poco conosciuta ma cruciale della storia americana, il default del debito sovrano del 1933, "quando il presidente Roosevelt, alle prese con le politiche monetarie restrittive della banca centrale, nel tentativo di far uscire il paese dalla depressione svalutò il dollaro rispetto all'oro, dimezzando istantaneamente il valore di tutti i contratti di debito. Oggi l'economia americana è così forte che nessuno crede possa fare default", racconta Rossi, "eppure è proprio quello che è successo 90 anni fa, ed è sempre bene rinfrescarsi la memoria, se non altro per capire i rischi di politiche monetarie restrittive troppo a lungo protratte nel tempo".
Gaia Rubera: parole e tecnologia per conquistare il mondo
Il potere economico e culturale, da sempre, si sposta verso Ovest. Dalla Mesopotamia agli Stati Uniti e, adesso ma soprattutto in futuro, alla Cina. "E lo fa, spiegano in How Transformative Innovations Shaped the Rise of Nations: From Ancient Rome to Modern America, di Gerard J. Tellis e Stav Rosenzweig, sfruttando le innovazioni tecnologiche". Il primo libro consigliato da Gaia Rubera, direttrice del Dipartimento di marketing, ripercorre in modo originale la storia dell'umanità. "Tutti i popoli che in un qualche momento della storia hanno soppiantato la civiltà precedente", dice Rubera, "si pensi per esempio ai Romani che grazie al calcestruzzo hanno costruito le prime vere strade e acquedotti, lo hanno fatto generando innovazione tecnologica. Questa innovazione, a sua volta, alimenta la crescita economica, il dominio nazionale e la leadership globale".
Il secondo volume, scritto anch'esso da uno studioso di marketing, si concentra sull'uso delle parole, come sottolinea il titolo, Magic Words: What to Say to Get Your Way, di Jonah Berger: "Che cosa rende un contenuto persuasivo? Quali parole vengono usate? Nel libro", dice ancora Gaia Rubera, "si utilizzano gli strumenti tipici dell'intelligenza artificiale per capire quali parole rendono i messaggi più convincenti e perché alcune parole hanno un impatto maggiore di altre. Tali parole sono più adatte a cambiare le menti, a coinvolgere il pubblico e a spingere all'azione. E' quello che fa il marketing da sempre, seguendo il famoso adagio "Content is king". Ma il libro, grazie a un approccio computazionale, sposta l'attenzione dalla sostanza alla forma. Il libro fornisce inoltre un insieme di strumenti e tecniche per motivare squadre, convincere giudici, ottenere finanziamenti dagli investitori".
Marco Tortoriello: con autocritica e apertura mentale si raggiunge la verità. Anche nel management
"Il management è una disciplina complessa e, non essendo una scienza esatta come la matematica o la fisica, si presta a volte a interpretazioni poco affidabili da parte di sedicenti "guru". Una lettura come questa invece, ci invita ad aprire la mente ad affinare il nostro spirito critico, e a mettere in discussione le nostre convinzioni, ed è davvero importante. E adatto a qualsiasi periodo dell'anno". Il libro consigliato da Marco Tortoriello, direttore del Dipartimento di management e tecnologia, è Think Again, di Adam Grant, e parte da una considerazione che sembra paradossale: "Le persone spesso più studiano, più accrescono il proprio bagaglio culturale e più si convincono di avere sempre ragione, arrivando alla radicalizzazione delle proprie convinzioni, che è l'esatto opposto dell'apprendimento. Adam Grant nel suo volume sembra volerci dire che imparare a mettere in discussione le proprie opinioni e aprire la mente è una strategia che può aiutarci a raggiungere posizioni di eccellenza sul lavoro e a distinguerci per saggezza nella vita". Questo è ancora più importante nell'era dei social, spiega Tortoriello, "dove chiunque può esporre anche la più strampalata delle opinioni e trovare comunque qualcuno online che gli dà ragione. Nella vita quotidiana troppi di noi preferiscono la comodità della convinzione al disagio del dubbio. Ascoltiamo le opinioni che ci fanno sentire bene, invece delle idee che ci costringono a impegnarci in una riflessione. Vediamo la divergenza di opinioni come una minaccia al nostro ego, piuttosto che come un'opportunità per imparare". E così i feedback negativi, che tanto ci spaventano, possono diventare un'ancora di salvezza. E vanno accettati con senso critico. "In questo libro Adam Grant libro utilizza un linguaggio semplice e alla portata di tutti, fornendo degli archetipi che rappresentano molto bene le nostre difficoltà nel porci dal punto di vista del nostro interlocutore nelle dinamiche relazionali, nonché la nostra resistenza al cambiamento. Dobbiamo essere aperti e critici con noi stessi, e pronti a considerare soprattutto i dati, che non mentono mai. Think Again ci spinge a considerare questo approccio come l'unico in grado di condurci alla verità".
Riccardo Zecchina: il negazionismo scientifico ha fatto vittime illustri. Il caso di Galileo
"Galileo: E i negazionisti della scienza, di Mario Livio, è il primo volume che voglio consigliare", spiega Riccardo Zecchina, direttore del Dipartimento di computing sciences. "Ciò che distingue questo libro è la sua chiara e brillante rappresentazione del confronto di Galileo con il negazionismo scientifico della sua epoca. Livio traccia un parallelo tra le sfide affrontate da Galileo e le questioni contemporanee in cui le prove scientifiche, come quelle del cambiamento climatico, hanno difficoltà a essere accettate e a diventare una forza trainante per i politici.
Inoltre", continua Zecchina, "il libro fa luce sulla vita accademica di Galileo, illustrando come egli abbia saputo destreggiarsi strategicamente tra le complessità del mondo accademico per concentrarsi sulle sue ricerche. A molti colleghi accademici farà piacere sapere che si tratta di una questione contemporanea che ha radici antiche".
"Come seconda lettura, invece, suggerisco Energia sostenibile - senza aria fritta di David JC MacKay.
È una lettura utile per chiunque sia interessato a comprendere le basi del consumo energetico e della sostenibilità. David JC MacKay, un fisico esperto di energia sostenibile che è stato consulente scientifico capo del Ministero dell'Energia e del Cambiamento Climatico del Regno Unito, ha realizzato un manuale di inestimabile valore che rende accessibile la modellazione matematica del consumo energetico.
Il libro, che può essere letto a moduli", dice ancora Zecchina, "si distingue per l'enfasi posta sull'utilizzo dei numeri per comprendere l'essenziale dell'energia e non degli aggettivi. Attraverso un'ampia gamma di esempi, MacKay illustra come calcolare il consumo energetico di diverse attività umane. Questo approccio quantitativo guida il lettore nella valutazione dell'efficacia delle politiche energetiche.
Non si tratta solo di un'esplorazione teorica, ma di una guida pratica che può essere utile a politici, educatori e individui per prendere decisioni informate per un futuro sostenibile".
Leggi anche: